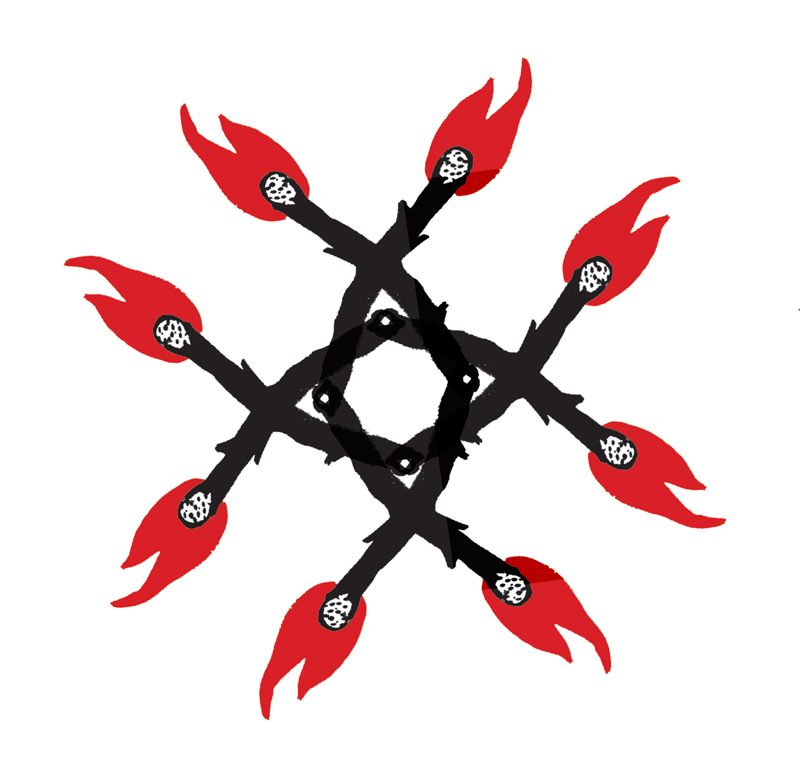È appena uscito per le edizioni Monitor il volume Un compagno. Storia di Ettore Davoli (a cura di Chiara Davoli), che racconta la vita del sindacalista e militante politico di origini calabresi e attivo a Roma, attraverso le sue parole e quelle di chi ha condiviso un tratto di strada con lui. Pubblichiamo di seguito la testimonianza che apre il volume: “Il mio cugino di campagna” di Giancarlo Davoli.
* * *
Nessuna battuta, tanto meno allusione rispetto al titolo di questo racconto: era letteralmente così che definivo mio cugino Ettore. Anche se poi la sua vita è andata in tutt’altra maniera.
La prima volta che lo vidi avevo, sì e no, nove anni. Approfittando di un parente che scendeva da Torino, i miei quell’estate mi mandarono in Calabria. Era pure la prima volta che uscivo da Roma. Della Calabria e di Taverna avevo solo i racconti di mio padre e di mia madre e, soprattutto, quelli terrorizzanti di mia zia Vittoria, fatti di fantasmi inquieti che comparivano in alcune notti e in alcuni luoghi precisi del paese.
La casa di Ettore si trovava su una piazzetta davanti alla chiesa di Santa Barbara. Aveva una particolarità, dovuta alla sua collocazione: si elevava su due piani, ma non vi si accedeva dal primo bensì dal secondo. Comunque, io la trovai accogliente e piena di vita. La famiglia di mio cugino era, per usare un eufemismo, numerosa; lui era l’ultimo di dodici figli e, in quella casa, anche se alcuni dei fratelli se n’erano già andati – chi era emigrato e chi s’era fatto una famiglia –, si stava abbastanza stretti. Io fui messo con i piccoli, che dormivano al primo piano, senza distinzione di genere, su due letti che li contenevano tutti.
Ettore aveva uno sguardo pulito, spavaldo e diffidente, che mi rendeva inquieto; mi studiava e cercava di capire quale differenza ci potesse essere tra di noi. Io, forte del fatto che avevo un anno più di lui, che venivo da Roma e che ero cresciuto tra i prati e le strade di Centocelle, un po’ me la tiravo. Ma lui, a scanso di equivoci, mise subito tra di noi una distanza, dandomi un soprannome: “il romano”. Ero “il romano” quando facevo qualcosa fatta bene ed ero “il romano” pure quando facevo qualcosa che non andava bene, e diciamo che erano più le volte che mi muovevo in maniera impacciata in quel nuovo contesto che altro.
La mattina ci si svegliava che era ancora buio, tra le cinque e le sei; ci si lavava sommariamente, si beveva in fretta una tazza di latte freddo in cui lui inzuppava un pane che chiamava pitta e che io evitavo con cura; poi, silenziosamente, per non svegliare gli altri, uscivamo per andare all’orto. In famiglia tutti lavoravano, ma la cura quotidiana dell’orto toccava al più piccolo e, visto che io avevo quasi la stessa età di Ettore, toccava pure a me.
L’orto era diviso in fasce o terrazzamenti che scendevano verso il fondo valle: alcune erano sostenute dalle radici dei vari alberi da frutta, altre erano invece sorrette da rinforzi di legno che ne definivano il perimetro. Uno stradello in discesa le percorreva tutte, congiungendo le une alle altre. Bisognava essere agili e avere forza nelle gambe per fare su e giù a chiudere e aprire i vari sbarramenti che permettevano all’acqua di scorrere nei solchi e irrigare zucchine, pomodori, cetrioli, insalata, radicchio e tante altre verdure. Fare ciò per me era divertente, anche se faticoso, mentre Ettore era come se facesse parte di quel paesaggio: si muoveva tra ortaggi e canali con grazia, velocità e senza alcuno sforzo, almeno così mi sembrava. Là, tra quelle timpe, Ettore era un re: ne conosceva ogni curva, ogni avvallamento, ogni scorciatoia. Usava il falcetto e la zappa, che era quasi più grande di lui, con maestria e perizia: uno per tagliare le erbacce, l’altra per rendere più profondi i solchi dove scorreva l’acqua.
Il mio battesimo dell’orto avvenne una mattina mentre risalivamo per tornare a casa per il pranzo. Una delle cose che avevo notato quasi subito in quella campagna era che là tutto era più grande e anche i colori erano diversi; per esempio, le lucertole erano di un verde vivo che, nelle mie scorribande nei prati di Centocelle, mai avevo visto; e anche le serpi, che io pensavo fossero grigio-verdi, lì avevano un altro colore: erano nere. Comunque, stavo bene attento a non dire a Ettore queste mie osservazioni: rimanevo sempre un “romano”. Ma lui, quasi intuendo questi miei stupori e, in qualche modo, anche paure, ogni tanto mi rassicurava dandomi dei suggerimenti.
Ma, come dicevo: stiamo risalendo su per lo stradello carichi di frutta e di verdure dentro cesti di vimini; nei pressi di un piccolo slargo, una grossa macchia nera attira la mia attenzione. Ettore è dietro di me; quando risaliamo si posiziona sempre così, forse per proteggermi. Attratto da quella macchia, mi avvicino e, come per magia, in un attimo quella si disunisce in mille rivoli quasi scomparendo; metto meglio a fuoco e capisco: sono serpi. Ne rimangono tre, una completamente srotolata al centro e le altre due di fianco che si stanno arrotolando assumendo la forma di una molla; mi sento toccare: è mio cugino che mi supera gridando “corri in salita”; io capisco in prima battuta solo “corri”, mollo il cesto e mi giro correndo verso la discesa; e mentre mi rendo conto che la frase di Ettore finisce con “salita”, sento arrivare prima una e poi un’altra frustata sulla schiena. Goffamente inverto la marcia e correndo lo raggiungo. Lui, appoggiato a un albero, è là che se la ride di cuore; le due frustate pizzicano da morire, ma quello che fa veramente male è la figura che ho fatto: “il romano” di Roma, cresciuto tra gli sterminati prati di Centocelle, messo in fuga e, per di più, colpito da due serpi innamorate.
La sera si andava a letto presto; la mattina dovevamo svegliarci all’alba, ma in realtà erano più le volte che questo non accadeva e così, quando tutta la casa dormiva, Ettore mi faceva un cenno e, vestendoci rapidamente, saltavamo dalla finestra; poi, evitando i vicoli più battuti per non fare incontri non voluti, arrivavamo nel corso del paese e, dopo un breve tratto, nella piazza; lì, sotto la statua di Mattia Preti, trovavamo altri fuggiaschi. Dopo un po’ di battute in dialetto stretto, di cui non capivo molto, usciva fuori il pallone e, subito, dopo una strana conta, si formavano le squadre.
In quelle accanite partite uscivano chiari i modi di essere di ognuno di noi. Mio cugino non aveva molta tecnica, ma si buttava nella mischia con coraggio, aiutando il compagno in difficoltà; generoso fino all’estremo, aveva una naturale propensione per il gioco collettivo.
In una di queste sfide senza esclusione di colpi, avvenne qualcosa che poi fece interrogare l’intero paese per diverso tempo e che, in qualche modo, mi vide protagonista, anche se involontario. Un avversario dribbla senza esitazione un mio compagno; gli vado incontro per fermarlo, ma lui, cercando di sorprendermi, fa partire un tiro che io, con la forza della disperazione, intercetto con il piede; la palla impazzita schizza in alto e va a sbattere violentemente contro la punta della spada del povero Mattia Preti, spezzandola. Un silenzio irreale cala sulla piazza; ci guardiamo senza parlare, poi scoppia all’unisono una fragorosa risata; qualcuno raccoglie il pezzo e, senza dircelo, sigilliamo un segreto che forse rivelo per la prima volta.
Per mesi l’intero paese e le sue istituzioni si interrogarono su chi potesse essere stato. Mattia Preti, pittore caravaggesco detto “il cavaliere calabrese”, era nato a Taverna ed era un vanto, un segno identitario per l’intero paese: la sua statua era considerata sacra o giù di lì. Le supposizioni furono molte e di diversa natura, e solo il tempo le fece sfumare, mitigando l’affronto.
C’è un gesto di mio cugino che è rimasto indelebile nella mia memoria, che mi diede la dimensione del suo altruismo e che vorrei fosse chiaro che non ha né connotati ideologici né tanto meno religiosi; credo che facesse parte della sua natura, se non altro perché è un gesto che risale a una fase della sua vita che potremmo definire, per economia di discorso, “prepolitica”.
L’orto per la famiglia di Ettore era il maggiore mezzo di sostentamento, le altre entrate erano misere e saltuarie. Questo lui lo sapeva perfettamente perché lo viveva sulla sua pelle. Più volte notai che il suo umore cambiava a seconda di quanta frutta e ortaggi riportavamo a casa alla fine della mattinata; per me, quando i cesti erano scarsi, era meglio perché si faceva meno fatica; per lui era il contrario: si scuriva e diventava intrattabile.
Per arrivare a casa c’era un’unica strada che passava sotto una specie di torre, affiancata a un palazzo antico che, senza un perché, a me metteva tristezza. Quella mattina, passando lì accanto, sentimmo delle voci che attrassero la nostra attenzione; in un attimo mio cugino capì, andò sotto la torre e, guardando in alto, fece un cenno. Dopo poco, vidi calare un piccolo cesto da una finestra piena di sbarre che si trovava nel punto più alto; non capivo e lo guardavo interrogativo, poi mi disse: “Sono carcerati” e, senza altre parole né esitazione, nonostante le nostre ceste quella mattina fossero parecchio scarse, prese della frutta e della verdura e le mise nel cestino, tirando poi la corda per far capire che potevano recuperarlo.
In una delle ultime telefonate, forse l’ultima, quando ormai la fase degli esami medici e delle diagnosi era diventata inutile, lui mi disse che la cosa che lo affliggeva di più, oltre al fatto di dover lasciare moglie, figlie, nipoti, amici e compagni, era quella impari partita che lui stava giocando con la morte; non capiva perché, se era ormai prossima, non si affrettasse ad arrivare; e, anche se ammetteva senza problemi di averne paura, aveva una voglia sfrenata di anticiparla, di chiudere quella partita, di non aspettarla più. Mi hanno detto che Ettore non è morto a letto. A me piace immaginare che lui, un attimo prima, l’abbia sentita arrivare, si sia alzato e le sia andato incontro con quel suo sguardo pulito, spavaldo e, forse, anche un po’ diffidente.